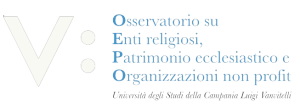Il 16 e il 17 settembre 2025, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, si è svolto il convegno “Legami in transito: genere, famiglia e diritto nella società in movimento” (Progetto PRIN E.S.O.D.I.), incentrato sull’analisi del fenomeno migratorio.
Nell’approfondire i fattori alla base dei flussi migratori, si è osservato come la famiglia ne rappresenti il motore indiscusso, abbracciando il fenomeno anche nelle sue fasi successive. Si è, infatti, constatato che la mancata osservanza degli obblighi culturali può anche significare per il migrante perdita di identità. Una specifica riflessione è stata dedicata alla c.d. famigration, allo scopo di adattare la disciplina sull’immigrazione alle peculiarità e criticità che reca con sé il diritto di famiglia (Prof.ssa Livia Saporito). Quest’ultima tematica è stata analizzata in ottica comparata guardando all’ordinamento svedese e greco in materia di riconoscimento di status in sede giurisdizionale, soprattutto nei casi in cui oggetto del giudizio fosse un istituto non contemplato dall’ordinamento ricevente in ambito familiare (Prof. Lucia Di Costanzo). Si è, poi, ricercata una definizione della libertà di circolazione all’interno del diritto d’immigrazione, attraverso un raffronto tra l’ordinamento nazionale, europeo ed internazionale. Tuttavia, con riguardo ai casi giurisprudenziali in materia, si è ritenuto che l’elemento multiculturale non incide mai in sede decisionale, ponendo la questione dal solo punto di vista del paese ospite di recezione. (Prof. Manuela Consito).Il pluralismo normativo che la circolazione familiare ha prodotto nei diversi ordinamenti giuridici ha indotto riflessioni circa il concetto di ordine pubblico internazionale, quale diritto centrale nel quadro dei rapporti giuridici transnazionali e strumento di controllo per l’applicazione di atti e leggi straniere (Dott.ssa Elena Napolitano). Sul conflitto culturale tra ordinamenti giuridici e sull’influenza del precetto religioso nell’agire quotidiano si è posta l’analisi del matrimonio poligamico, nel tentativo di ricercare schemi giuridici, di derivazione giurisprudenziale, che possano tutelare quantomeno i soggetti deboli della formazione familiare, quali le mogli e la prole (Dott.ssa Serena Esposito Russo). Ulteriore aspetto affrontato, in termini di ricostituzione dell’unità familiare, è stato il complesso istituto del ricongiungimento familiare, la cui rilevanza nel contesto europeo si è rintracciata con evidenza tramite un’analisi statistica dei permessi di soggiorno del periodo 2017-2023 (Prof.ssa Manuela Consito; Prof.ssa Roberta Pace).
Evidenziando come il migrante, con il suo bagaglio culturale e religioso, concorra ad arricchire in maniera diversificata la società, sotto un profilo economico, sociale e spirituale (Dott.ssa Rogeria Azevedo), è stato introdotto uno dei contesti pubblici in cui tale diversità si manifesta, quale la scuola. Tramite l’analisi delle linee guida ministeriali del 2014 in tema di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, sono state rilevate criticità e contraddizioni insite nelle prassi operative a cui si auspica di provvedere per garantire il rispetto dei principi di solidarietà, uguaglianza e libertà religiosa (Dott. Antonio Ventrone). In riferimento al diritto penitenziario, si è approfondito il diritto all’affettività e alla sessualità in carcere, con uno sguardo ai centri di permanenza per i rimpatri in cui sono trattenuti i migranti in condizioni di irregolarità, che assumono le fattezze di strutture detentive vista la presenza della polizia penitenziaria (Prof.ssa Mena Minafra). Con uno sguardo all’immigrazione nel contesto sudamericano, sono stati rilevati cambiamenti significativi, posto che attualmente sono gli stessi sudamericani che migrano all’interno del continente (Dott.ssa Flor Maria Avila). Da un diverso punto di vista, è stato affrontato il ruolo degli enti religiosi all’interno delle dinamiche migratorie, identificati come reti di supporto sociale, economico e culturale per i migranti, ai quali viene fornita assistenza pratica e garantita continuità con la tradizione del paese d’origine, assumendo un ruolo rilevante nel post accoglienza e nell’integrazione (Prof.ssa Ludovica Decimo). In tale contesto è stata, poi, analizzata la disciplina del resettlment, con le relative criticità emerse in relazione alla opacità delle liste dei beneficiari, e dei corridoi umanitari, rilevando, in particolare, come gli accordi sui corridoi umanitari potrebbero costituire esplicazione del principio di sana cooperatio e bilateralità tra Stato e Chiesa (Prof. Francesco Sorvillo). Per quel che riguarda la giurisprudenza islamica, sono stati rimarcati i profili critici insiti nel diritto islamico, con riferimento alla necessaria reinterpretazione delle fonti per adeguarle alla realtà mutata ed alle problematiche, legate all’osservanza dei precetti religiosi, che lo spostamento dei musulmani comporta (Prof. Amr Abdelaty Saleh).
Tramite una prospettiva ecclesiale, è stato ricostruito uno statuto per i migranti sulla base delle norme dell’ordinamento canonico, auspicando che si proceda ad una sua formalizzazione, stante il primato della persona. Ne è emerso il diritto ad una cura pastorale specifica dei migranti, rispettosa delle diversità, la cui fruizione non è sempre garantita nelle molteplici comunità (Prof. Luigi Sabbarese). Inoltre, sono state approfondite le problematiche relative al minore non accompagnato, soprattutto con riferimento all’esercizio della responsabilità genitoriale e della libertà religiosa del minore, ponendo attenzione alla natura sociale e morale della questione (Prof. Antonio Foderaro). Portando l’esperienza della Chiesa Cattolica, si è messo in luce il passaggio della sua azione pastorale, inizialmente rivolta ai soli migranti cattolici, verso la realtà umana e sociale delle migrazioni, il che richiama l’essenziale rispetto dei diritti fondamentali anche dei non cattolici, verso cui la Chiesa ha le sue responsabilità (Prof. Paolo Palumbo). Con riguardo alla disparitas cultus, si è posta l’attenzione sul canone 1124 c.i.c., relativo al matrimonio tra un battezzato nella Chiesa cattolica con un battezzato in altra comunità. Si è rilevato che tale impedimento, poiché meramente impediente, depone a favore del dialogo interreligioso, posto che il matrimonio resta canonicamente valido, seppur si configuri una illiceità nel caso di mancato rilascio della licenza (Prof. Raffaele Santoro). Uno degli ambiti in cui le diverse appartenenze religiose entrano in conflitto è certamente quello dell’educazione religiosa del minore, conflitto che si acuisce nel caso di separazione tra i coniugi. Si è approfondita, pertanto, la negoziazione assistita per comprendere fino a che punta possa essere “negoziata” la libertà religiosa del minore, tenendo presente la necessaria osservanza del best interest of child (Prof. Federico Gravino).
Con attenzione specifica ai profili successori, è stato indagato il ruolo della volontà del de cuius in sede di scelta della legge applicabile alla successione, in quanto istituto marcatamente interculturale, e gli strumenti giuridici a disposizione dello stesso per provvedervi (Prof. Ilaria Riva). Su tale linea si è posta l’analisi della sepoltura per i fedeli musulmani e le relative questioni successorie. Sono stati rintracciati i limiti della disciplina coranica in materia, quali la previsione di quote prestabilite per gli eredi prediligendo l’erede maschio, l’esclusione dei figli naturali e l’impedimento a succedere in caso di disparitas cultus. (Prof.ssa Miriam Abu Salem).
Secondo una prospettiva economica, è stato trattato il c.d. migrant banking, quale insieme di prodotti e servizi bancari e finanziari rivolti ai migranti, finalizzati a garantire inclusione e a valorizzare un segmento di mercato in costante espansione (Prof.ssa Ida D’Ambrosio). In tal senso, analizzando i fattori che incidono sull’inclusione finanziaria, quali la vulnerabilità linguistica, economica, etnica e culturale, si è osservato come il migrante sia spiccatamente connotato da una evidente vulnerabilità (Prof. Gabriele Carapezza Figlia).
Il convegno ha offerto una ricca riflessione multidisciplinare sulle ripercussioni delle migrazioni in ambito familiare, economico e successorio, mettendo in luce le sfide normative e culturali poste dalla mobilità umana. Dai diversi spunti è, dunque, emersa l’importanza di adottare un approccio giuridico più inclusivo, pluralista ed attento alla complessità identitaria del migrante.